Cultura
In occasione di tre ricorrenze dal profondo valore civico, il 25 aprile (anniversario della Liberazione), il 2 giugno (festa della Repubblica italiana) e il 4 novembre (giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate), sei istituzioni pubbliche che hanno sede in edifici storici torinesi aprono le loro porte per offrire un percorso insolito, nel cuore della città.
L’evento è promosso dalla Città di Torino - Presidenza del Consiglio comunale e dalla Prefettura di Torino, con la collaborazione della Città metropolitana di Torino, di Turismo Torino e Provincia, per il Ministero della Cultura, dei Musei Reali e dell’Archivio di Stato di Torino, e per la Fondazione Torino Musei, di Palazzo Madama.
L’itinerario ha inizio a Palazzo Civico, storica sede del municipio cittadino, inserita nel nucleo originario della Torino di fondazione romana. Il percorso di visita, la cui partenza è prevista dal Cortile d’Onore del Palazzo stesso, di impianto tipicamente barocco, si snoderà attraverso le sue Sale Auliche: lo Scalone d’Onore seicentesco, la neoclassica Sala dei Marmi e il suo loggiato, la Sala delle Congregazioni, la splendida Sala Rossa, cuore della vita amministrativa torinese, per concludersi presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale che, eccezionalmente, aprirà le sue porte ai visitatori.
Percorse le vie che collegano il Palazzo di Città con Piazza Castello, si raggiungono i Musei Reali per la visita nelle sale di rappresentanza di Palazzo Reale, centro di comando della dinastia sabauda e prima reggia dell’Italia unita. Si sale al piano nobile attraverso lo Scalone d’Onore, commissionato dal re Vittorio Emanuele II all’architetto Domenico Ferri nel 1861, all’indomani dell’Unità d’Italia, quando per i Savoia si prospettava un ruolo nazionale con Torino capitale del nuovo regno. È un’architettura di gusto eclettico, con una decorazione ispirata a modelli barocchi.
Si entra nel grande Salone delle Guardie Svizzere, si attraversano numerose sale fastose tra cui quella del trono e quella del Consiglio, nella quale il 4 marzo 1848 fu siglato lo Statuto Albertino, per giungere nella Galleria Beaumont, che prende il nome dal pittore di corte incaricato di dipingerne la volta. Qui ha sede l’Armeria Reale, che accoglie la raccolta dinastica di armi e armature antiche. Aperta al pubblico nel 1837 è una delle istituzioni culturali che Carlo Alberto promuove insieme alla quadreria di Palazzo Madama, futura Galleria Sabauda, l’Accademia Albertina e la Biblioteca Reale. Al termine si percorre lo scalone alfieriano, che collega gli appartamenti reali con le costruzioni destinate alle Segreterie di Stato, agli Archivi di Corte e al Teatro.
Si giunge al Palazzo delle ex Regie Segreterie di Stato, antica sede di ministeri sabaudi e dal 1866 della Prefettura di Torino. Il percorso prevede, la Galleria affacciata sui Giardini Reali realizzata da Benedetto Alfieri tra il 1738 e il 1756, lungo ambiente di raccordo tra la Galleria Beaumont e gli Archivi di Corte, che si apre in cima allo spettacolare scalone alfieriano, affrescata dal bolognese Pelagio Palagi durante la stagione del rinnovamento dei reali palazzi voluto da Carlo Alberto. Un affaccio sull’infilata delle sale di rappresentanza, allestite sempre da Alfieri, affrescate da Francesco Gonin e arredate con i migliori pezzi provenienti dal mobiliere di Palazzo Reale e dalle Raccolte Civiche culminante nell’ufficio che fu di Camillo Benso Conte di Cavour, una piccola stanza dalle pareti blu, la più vicina a Palazzo Reale, rimasta intatta dalla sua prematura scomparsa nel 1861. Tante le curiosità come la piccola porta segreta, alle spalle della sua scrivania, da dove si può raggiungere Palazzo Reale. Anche l’ufficio del Prefetto è aperto al pubblico.
Dalla Galleria si passa all’aula del Consiglio della Città metropolitana di Torino, già Provincia di Torino. Nel 1864 Torino non è più capitale. Gli intendenti delle Segreterie vengono sostituiti dai Prefetti ai quali viene collegato un consiglio provinciale. L’ampia sala dedicata alle riunioni del consiglio, con le sue decorazioni, è un’interessante espressione dei modelli eclettici propri del periodo umbertino, ispirati alla tradizione pittorica e architettonica italiana.
Dall’aula metropolitana si giunge all’ Archivio di Stato le cui sale furono ideate ancora una volta da Juvarra per conservare i documenti dell’Archivio di Corte, tuttora custoditi nelle «guardarobe» che circondano le stanze. Originariamente i Regi Archivi erano uno dei luoghi più segreti dello Stato sabaudo: potevano accedervi solo il re, i suoi ministri e gli archivisti. Questa parte della visita termina con il passaggio attraverso lo scalone juvarriano, antica via di accesso e di uscita dell’Archivio di Corte.
Le visite con partenza alle 14.30 e alle 15.00 si concluderanno a Palazzo Madama ove, accompagnati dal direttore Giovanni C.F. Villa, si avrà piena coscienza di quella che Guido Gozzano definì «la casa dei secoli» poiché «Nessun edificio racchiude tanta somma di tempo, di storia, di poesia». Un Palazzo Madama narrato nel suo essere ideale generatore dell’Italia unita e dell’Europa dei popoli, con la visita che si soffermerà nella Sala del Senato del Regno d’Italia che «volle preparò sancì l’unità nazionale. Costituì il Regno d’Italia, proclamò Roma capitale», come recita il fastigio a lettere d’oro in essa posto, e nella Sala Feste in cui, il 18 ottobre 1961, il Consiglio d’Europa firmò la Carta Sociale Europea, la carta dei diritti dei popoli d’Europa.
Modalità di visita
I gruppi saranno accompagnati nella visita dai volontari delle istituzioni coinvolte, insieme a studentesse e studenti delle scuole secondarie impegnati in un progetto di alternanza scuola-lavoro.
L’ingresso è gratuito esclusivamente su prenotazione. Per l’accesso in Prefettura è necessario esibire un documento di identità.
Informazioni e Prenotazioni: www.turismotorino.org/visite_palazzi_istituzioni
Turno A: partenza da Palazzo Civico ore 14.30; partenza da Palazzo Reale ore 16.00; la visita prosegue a Palazzo Madama
Turno B: partenza da Palazzo Civico ore 14.45; partenza da Palazzo Reale ore 16.15
Turno C: partenza da Palazzo Civico ore 15; partenza da Palazzo Reale ore 16.30; la visita prosegue a Palazzo Madama
Turno D: partenza da Palazzo Civico ore 15.15; partenza da Palazzo Reale ore 16.45
Massimo 30 persone per Gruppo.
Accessibilità
Il percorso è accessibile a persone con disabilità motoria, ad eccezione dello scalone di collegamento tra l’Armeria e la Prefettura. Sarà possibile utilizzare un percorso alternativo, con passaggio esterno, oppure entrare direttamente nella Prefettura saltando i Musei Reali, che potranno essere visitati in altra data.
- Dettagli
- Categoria: Cultura
Cultura
Per ricordare il 500° anniversario della nascita del compositore e organista Giovanni Pierluigi da Palestrina l'associazione culturale Contatto, nell'ambito della rassegna Chivasso in Musica, sostenuta dal Bando MusicArt della Città di Chivasso e patrocinata dalla Città metropolitana di Torino, ha organizzato un concerto in programma sabato 5 aprile alle 21 nel Duomo Collegiata di Santa Maria Assunta.Il coro misto Musicaviva, diretto da Daniela Lepore, eseguirà la “Missa Fratres Ego Enim” di Palestrina. Alla consolle dell'organo Felice Bossi del 1843 siederà l'organista Aldo Bergamini, che inframmezzerà i brani corali con composizioni organistiche di Girolamo Frescobaldi. L'attrice Carla Vezza leggerà i brani evangelici e il Salmo tratti dalla liturgia della Messa “In Coena Domini" del Giovedì Santo. Si tratterà, quindi, di un concerto spirituale, proprio del tempo di Quaresima (fa eccezione il Gloria della Messa palestriniana) in preparazione alla Domenica delle Palme (13 aprile) e al Triduo Pasquale.
Chi desidera avere il posto riservato può scrivere a info@associazionecontatto.it entro e non oltre la mattina di sabato 5 aprile. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito Internet www.associazionecontatto.it
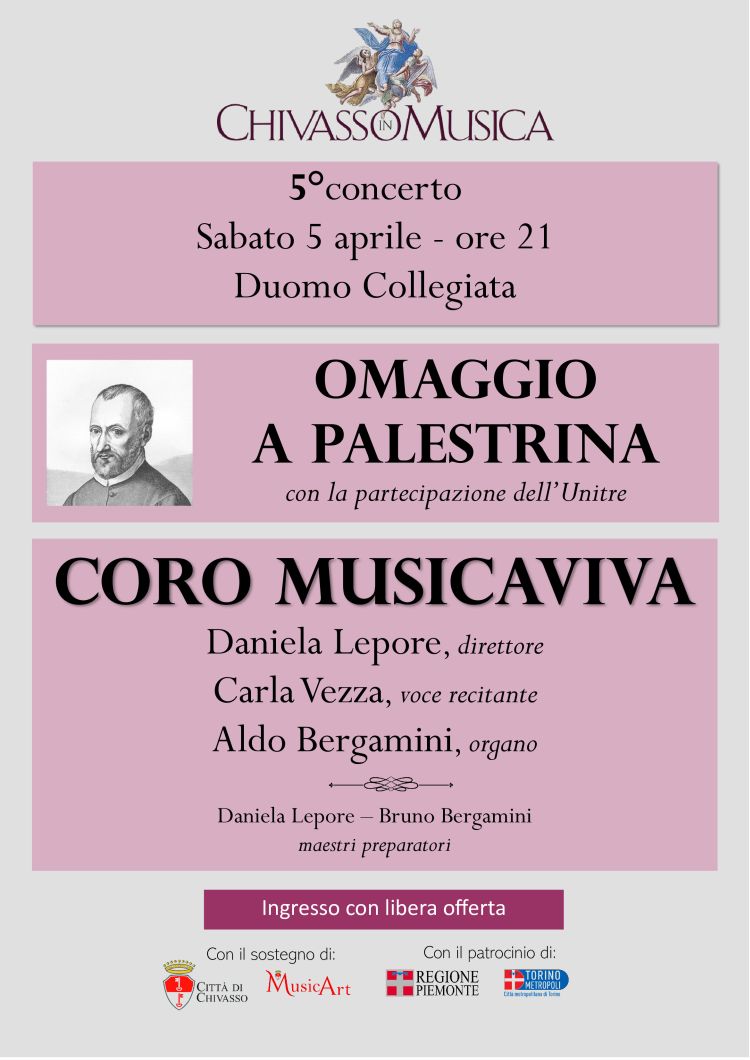
- Dettagli
- Categoria: Cultura
Cultura
Nel primo fine settimana di aprile i Comuni di Buttigliera Alta, Rosta ed Avigliana e la Fondazione Ordine Mauriziano celebreranno il 650° anniversario della nascita del pittore Giacomo Jaquerio, massimo rappresentante in Piemonte dell’arte tardo-gotica, attivo tra Torino, Ginevra e la Savoia, noto soprattutto per gli affreschi che realizzò a partire dal 1410 per decorare gli interni della Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso. Il programma delle iniziative culturali, delle rievocazioni storiche, dei momenti musicali e delle escursioni guidate nei dintorni della Precettoria di Sant’Antonio è stato illustrato nel corso di un incontro che si è tenuto nella sala panoramica al 15° piano della sede di corso Inghilterra della Città metropolitana di Torino.
Erano presenti il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, la Consigliera metropolitana delegata al turismo Sonia Cambursano, la dottoressa Marta Fusi, direttrice della Fondazione Ordine Mauriziano, gli amministratori locali, tra i quali i Sindaci di Buttigliera Alta, Rosta e Avigliana, Alfredo Cimarella, Domenico Morabito e Andrea Archinà.
I BUS NAVETTA PER RAGGIUNGERE SANT’ANTONIO DI RANVERSO
In occasione della presentazione, sono state dettagliate le modalità con cui, sabato 5 e domenica 6 aprile, le persone che non intendono o non possono raggiungere la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso con mezzi propri potranno usufruire gratuitamente dei bus navetta in partenza da Avigliana e da Rivoli per iniziativa della Città metropolitana di Torino e della Città di Rivoli. In entrambe le giornate il bus navetta da Avigliana, programmato dalla Città metropolitana di Torino nell’ambito del PUMS-Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, partirà dalle 14 in avanti da piazza De Andrè alla volta del Santuario della Madonna dei Laghi, per consentire la visita ai dipinti di Jaquerio. Il bus raggiungerà poi la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso. È prevista una corsa ogni ora e mezza circa. La navetta Rivoli-Sant’Antonio di Ranverso partirà inveceda piazzale Mafalda di Savoia dalle 14 in avanti, per iniziativa della Città di Rivoli, che dal punto di vista organizzativo si appoggia al Consorzio Turismovest. L’ultima corsa è prevista per le 19.
LA RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO E IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI
Gli eventi del 5 e 6 aprile si inseriscono in un progetto di riqualificazione del polo artistico e culturale di Sant’Antonio di Ranverso, oggetto di importanti investimenti e restauri curati dalla Fondazione Ordine Mauriziano, che comprendono anche l’Ospedaletto e la Cascina Bassa.
Sabato 5 aprile si terrà la conferenza celebrativa, che si aprirà alle 9,30 con il saluto delle autorità, seguito dagli interventi delle storiche e critiche dell’arte Cristina Scalon e Arabella Cifani, che si soffermeranno sul polo di Ranverso nelle carte dell’Archivio della Fondazione Ordine Mauriziano e sulla rivalutazione della figura di Giacomo Jaquerio. Seguirà l’intervento dell'architetto Luigi Valdemarin sui restauri del complesso monumentale. Alle 15 è in programma un momento dedicato alle scuole, curato da Serena Fumero. Alle 17 si terrà un concerto del coro degli Alpini di Rosta e della corale “Il bramito” di Bussoleno. Domenica 6 aprile si terranno le rievocazioni storiche e, alle 9,30, inizierà una camminata culturale ad anello di 3,5 km, con partenza e arrivo alla Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso e tappa alla cappella di Madonna dei Boschi per visitare gli affreschi della scuola jaqueriana. Chi è più allenato potrà seguire il percorso di 8 km, che prosegue lungo la pista ciclo pedonale “Just the Woman I Am” sino alle scuole secondarie Giacomo Jaquerio e alla Villa San Tommaso nel parco Rosa Luxemburg, sempre con arrivo a Sant’Antonio di Ranverso. Nel pomeriggio alle 16,30 è in programma la sfilata dei gruppi storici “Conte Verde” di Rivoli, “Conte Rosso” di Avigliana, “Il filo della memoria” e “Marchesi Carron di San Tommaso” di Buttigliera. Alle 17 il programma degli eventi si chiuderà con il concerto della Filarmonica San Marco.
A giudizio di Marta Fusi, direttrice della Fondazione Ordine Mauriziano, “l’evento organizzato per il 650° anniversario della nascita di Giacomo Jaquerio sottolinea l’importanza della collaborazione e della sinergia tra gli enti, al fine di promuovere e valorizzare un importante bene artistico. La Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, infatti, custodisce un capolavoro che è una delle poche opere firmate da un pittore che è considerato uno dei maggiori esponenti del gotico internazionale in Piemonte”.
“Abbiamo fortemente voluto promuovere un evento dall’ampio respiro culturale, per porre l’accento sul cuore del patrimonio artistico del nostro territorio, celebrando e contribuendo alla riscoperta di un artista del calibro di Giacomo Jaquerio. - commenta il Sindaco di Buttigliera Alta, Alfredo Cimarella - Da molti anni, le nostre amministrazioni lavorano, in collaborazione con la Regione e la Fondazione Ordine Mauriziano, in direzione della riqualificazione e del rilancio turistico di questo eccezionale complesso monumentale, cerniera tra la cintura metropolitana di Torino e la valle di Susa, punto importante lungo la via Francigena”.
Per il primo cittadino di Rosta, Domenico Morabito, “le iniziative programmate il 5 e 6 aprile sono un’occasione straordinaria per far conoscere il nostro territorio. Parliamo della meravigliosa cornice della Collina Morenica di Rivoli. È un territorio raggiungibile in treno da Torino e, scendendo alla stazione di Rosta, si può inforcare una bicicletta e scoprire un ambiente meraviglioso. In vista del 5 e 6 aprile, le nostre scuole e le nostre associazioni collaborano con gli uffici comunali, per dimostrare che, oltre ad un territorio bellissimo, da noi c’è una comunità che saprà dare il meglio di sé”.
“Avigliana ha un legame storico con la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, voluta dal conte Umberto III di Savoia, nato proprio ad Avigliana. Dietro l’altare del nostro santuario della Madonna dei Laghi vi è un pilone dedicato alla Madonna del Latte, che Umberto III volle far ridipingere in stile jaquariano. - sottolinea il Sindaco Andrea Archinà - La Precettoria fa parte di un nucleo di arte e architettura medioevale di assoluta eccellenza. Da questo punto di vista è importante la sperimentazione da parte della Città metropolitana di un bus navetta che collega i luoghi storici del nostro territorio in modo sostenibile”.
“Le iniziative del primo fine settimana di aprile a Buttigliera Alta, Avigliana e Rosta sono il frutto di un importante lavoro per mettere in rete le eccellenze della Bassa Valle di Susa, al fine di promuovere il turismo lento e sostenibile, su cui il territorio può puntare carte importanti. - sottolineano il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo e la Consigliera metropolitana delegata allo sviluppo economico e al turismo, Sonia Cambursano - La Città metropolitana apprezza e sostiene questa impostazione e i bus navetta gratuiti sono il riconoscimento tangibile della validità dei progetti in corso di elaborazione e realizzazione”.
VITA E OPERE DI GIACOMO JAQUERIO
Giacomo Jaquerio è considerato uno dei maggiori esponenti della pittura tardogotica in Piemonte, attivo nella prima metà del Quattrocento. Nato nel 1375 circa a Torino da una famiglia con una lunga tradizione nella pratica della pittura, visse la prima parte della sua vita tra continui spostamenti fra Torino, Ginevra, Thonon-les-Bains ed altre località d’oltralpe, lavorando come pittore di corte al servizio di Amedeo VIII di Savoia e del principe Ludovico di Acaja e ricevendo commesse da istituzioni religiose e da importanti casate nobiliari. Dal 1429 in poi abitò stabilmente a Torino, dove ricoprì anche le cariche pubbliche di consigliere del Comune e tesoriere. Della sua vasta produzione solo pochissime opere sono documentate e il primo documento certo è proprio la sua firma, scoperta nel 1914 sugli affreschi della Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, databili intorno al 1410, epoca in cui l’artista doveva già essere a capo di una fiorente bottega. La “Salita al Calvario” è il suo capolavoro caratterizzato da toni marcatamente realistici di crudeltà e dolore. Jaquerio morì tra il 1445 e il 1453, quando i documenti riportano i nomi della moglie vedova e degli eredi. La sua bottega fu ancora attiva nella seconda metà del XV secolo: al suo entourage e ai suoi modelli, costituiti da cartoni e matrici per la realizzazione di motivi decorativi in serie, sono riconducibili numerose opere presenti nei territori del ducato sabaudo e di diretta discendenza dalle pitture della Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso.
VISITARE SANT’ANTONIO DI RANVERSO
La Precettoria è visitabile dal mercoledì alla domenica dalle 9,30 alle 13 (ultimo ingresso alle 12,30) e dalle 14 alle 17.30 (ultimo ingresso alle 17). Il biglietto d’ingresso intero costa 5 euro, ridotti a 4 euro per i minorenni, gli over 65 e i gruppi di almeno 15 persone. I bambini fino a 6 anni e i possessori dell’Abbonamento Musei hanno l’ingresso gratuito. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare dal mercoledì alla domenica il numero telefonico 011-6200603 o scrivere a ranverso@biglietteria.ordinemauriziano.it e maggiori informazioni sono reperibili nel sito Internet www.ordinemauriziano.it
- Dettagli
- Categoria: Cultura
Cultura
Da sabato 15 marzo riprendono le visite guidate nelle ex miniere di talco Paola e Gianna di Prali, gestite dall’Ecomuseo delle miniere e della Valle Germanasca. Anche nel 2025 la Città metropolitana di Torino riconosce con il suo patrocinio il valore culturale e storico delle iniziative dell’Ecomuseo, che dagli anni ‘90 valorizza le tradizioni e le installazioni minerarie delle Valli Chisone e Germanasca. L’attività estrattiva è stata per lungo tempo il motore economico delle due valli e ne ha fortemente caratterizzato il paesaggio.Alla fine degli anni ’80 la “coltivazione” del talco di Prali sembrava giunta al capolinea e il patrimonio minerario rischiava di andare perduto irrimediabilmente: i macchinari arrugginivano, le strutture rischiavano di crollare, gli archivi si dissolvevano e rischiava di scomparire la memoria della tecnologia, del lavoro e dei sacrifici dei minatori.
Nel 1993 l’allora Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, sull’esempio di progetti avviati con successo in Gran Bretagna, Francia, Germania e Austria, avviò, nell’ambito di un’intensa cooperazione transfrontaliera, un progetto turistico-culturale di conservazione e valorizzazione del patrimonio minerario. Nel 1998 nacque ScopriMiniera, la proposta di tour guidati nelle gallerie della miniera Paola, alla scoperta della vita e del lavoro dei minatori della Val Germanasca. Grazie alle connessioni con la realtà culturale e ambientale locale, ScopriMiniera ha creato e consolidato un movimento turistico e alcuni posti di lavoro. I risultati ottenuti, le nuove capacità e competenze acquisite, le relazioni create hanno stimolato e contribuito alla creazione del progetto di un Ecomuseo del territorio della Val Germanasca, riconosciuto nel 2003 dalla Regione Piemonte.
A ScopriMiniera si è affiancato da alcuni anni il percorso ScopriAlpi nella miniera Gianna, dove si può vedere il punto esatto in cui rocce originatesi negli oceani della Tetide sovrastano rocce di origine continentale, confermando la teoria che attribuisce la formazione delle Alpi allo scontro tra le placche continentali africana ed europea. Aquasi 2 km di profondità dalla superficie, le gallerie della miniera Gianna hanno intercettato e reso visibile il contatto tra le due placche tettoniche e la cicatrice che testimonia lo scontro avvenuto 65 milioni di anni orsono tra i due continenti. Il percorso conduce i visitatori attraverso gli anfratti, le gallerie e le strutture di una miniera aperta oltre 60 anni fa e utilizzata fino al 1995 per estrarre un talco bianco purissimo e apprezzato in tutto il mondo. Maxi cartografie, videoproiezioni e installazioni multimediali, una “finestra di interpretazione geologica”, luci, suoni e voci narranti, apparecchiature e scenografie accompagnano i visitatori nelle tre ore di esplorazioni e scoperte.
Tutti i dettagli sulle visite guidate su prenotazione delle miniere e sulle attività didattiche dell’Ecomuseo sono consultabili nel sito Internet www.ecomuseominiere.it

- Dettagli
- Categoria: Cultura
Cultura
La celebrazione del Santo patrono S.Eldrado come ogni anno scandisce la ripresa delle visite all'Abbazia di Novalesa, gioiello medievale di arte, storia e cultura in Val Cenischia: un bene di proprietà da molti anni di Città metropolitana di Torino, affidato alle cure della comunità monastica benedettina.Da sabato 15 marzo l'Abbazia riapre ai visitatori con i seguenti orari: visite Abbazia sabato ore 10.30 e 11.30, domenica ore 11.30; visite museo archeologico sabato e domenica ore 11-13.
Gruppi e scuole possono prenotare una visita dedicata - tranne al lunedì - scrivendo a viste@abbazianovalesa.org
Quest'anno, per i visitatori di apre una nuova possibilità in aggiunta al consueto percorso alla scoperta delle Cappelle all'interno dell'Abbazia: è entrata infatti nel circuito "Chiese a porte aperte" la Cappella della Maddalena. Si tratta di un'occasione unica e nuova per entrare ad ammirare la Cappella, esterna ai muri dell'Abbazia e finora chiusa al pubblico.
"Chiese a porte aperte" è il progetto che consente di visitare autonomamente i beni culturali ecclesiastici del Piemonte e della Valle d’Aosta con l’ausilio delle nuove tecnologie. L’applicazione gestisce molteplici operazioni dalla prenotazione della visita all'apertura automatizzata della porta: una volta effettuato l’accesso tramite QR si viene guidati alla scoperta del bene al suo interno.
"Siamo davvero contenti che il percorso di visite alla scoperta della Abbazia della Novalesa si amplii - commenta il vicesindaco di Città metropolitana di Torino Jacopo Suppo - si tratta di un tassello importante nell'impegno della comunità monastica benedettina e del nostro Ente verso la celebrazione a gennaio 2026 del 1300° anniversario della fondazione di questo bene".
- Dettagli
- Categoria: Cultura
Cultura
Nel primo fine settimana di aprile i Comuni di Buttigliera Alta, Rosta ed Avigliana e la Fondazione Ordine Mauriziano celebreranno il 650° anniversario della nascita del pittore Giacomo Jacquerio, massimo rappresentante in Piemonte dell’arte tardo-gotica, attivo tra Torino, Ginevra e la Savoia, noto soprattutto per gli affreschi che realizzò a partire dal 1410 per decorare gli interni della Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso.Il programma delle iniziative culturali, delle rievocazioni storiche, dei momenti musicali e delle escursioni guidate nei dintorni della Precettoria di Sant’Antonio sarà illustrato nel corso di un incontro in programma lunedì 17 marzo alle 14,30 nella sala panoramica al 15° piano della sede di corso Inghilterra della Città metropolitana di Torino.
Saranno presenti il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, la Consigliera metropolitana delegata al turismo Sonia Cambursano, Marta Fusi, direttrice della Fondazione Ordine Mauriziano, i Sindaci di Buttigliera Alta, Rosta e Avigliana, Alfredo Cimarella, Domenico Morabito e Andrea Archinà.
In occasione della presentazione, saranno anche dettagliate le modalità con cui, sabato 5 e domenica 6 aprile, le persone che non intendono o non possono raggiungere la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso con mezzi propri potranno usufruire gratuitamente dei bus navetta in partenza da Avigliana e da Rivoli per iniziativa della Città metropolitana di Torino e della Città di Rivoli.
I colleghi giornalisti sono cordialmente invitati ad intervenire
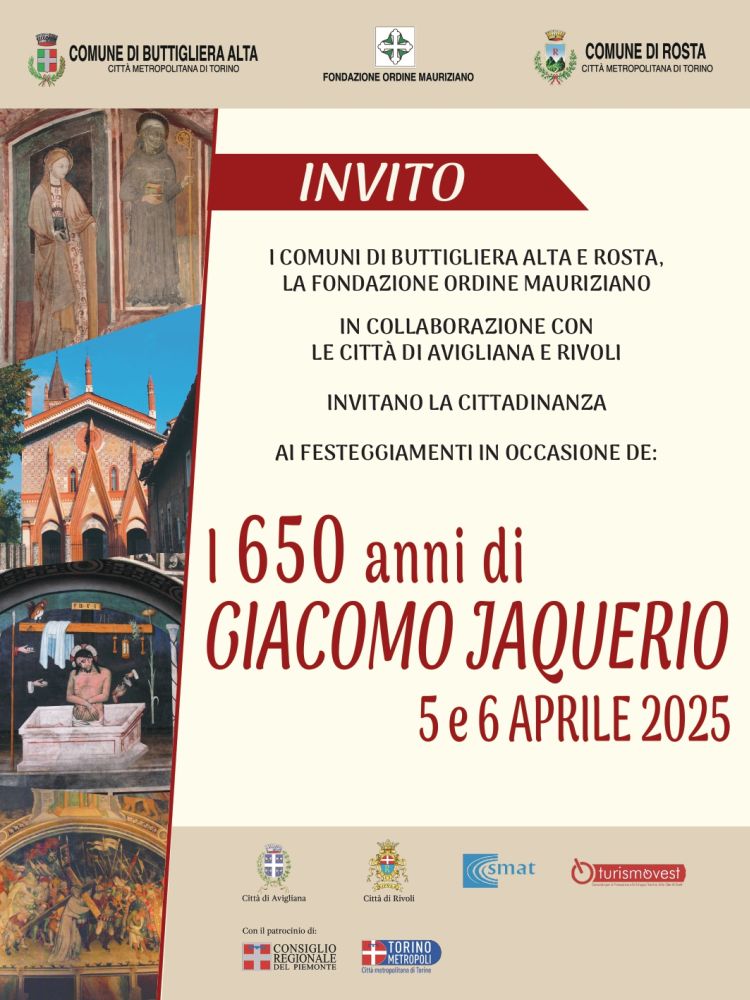
- Dettagli
- Categoria: Cultura
Cultura
Si chiama Attraversamento Meridiano il progetto artistico frutto della collaborazione tra il Comune di Castellamonte e le Città della Baia della Ceramica (Savona, Albissola Marina, Albissola Superiore e Celle Ligure).
Per sancire l'inizio del questo nuovo percorso, nei giorni scorsi il sindaco di Castellamonte e consigliere delegato della Città metropolitana di Torino, Pasquale Mazza, l’assessore alla Cultura Claudio Bethaz ed il capogruppo di maggioranza Alessandro Musso, accompagnati dal curatore della Mostra della Ceramica di Castellamonte Giuseppe Bertero e dai ceramisti locali Luca Gris, Guglielmo Marthyn, Roberto Perino e Maria Teresa Rosa, sono stati accolti nel Comune di Savona dal sindaco Marco Russo e dall’assessore alla Cultura Nicoletta Negro.
Il progetto, nato nel 2024 nel corso della 63^ edizione della Mostra della Ceramica di Castellamonte, è frutto di un’idea del noto conduttore di Linea Verde Giuseppe Calabrese, direttore artistico del Festival della Reciprocità delle Tre Terre Canavesane, e del ceramista e cartapestaio materano Raffaele Pentasuglia. L’obiettivo del progetto è quello di collegare fisicamente ed idealmente tutte le città aderenti ad AiCC – Associazione italiana Città della Ceramica – grazie ad una mandria di mucche in ceramica, tutte elaborate sullo stesso modello di bovino podolico ma rese uniche dall’estro e dalla personalità di ogni singolo artista, che tramite una vera e propria transumanza andrà ad ampliarsi ed a viaggiare in tutta la Penisola.
L’opera corale, che vuole porre l’attenzione non solo sull’aspetto artistico ma anche su quelli legati all’ambiente, alla stagionalità ed alle singole specificità dei territori, si avvale della collaborazione di Ambrogio Sparagna per la composizione delle musiche e di teli realizzati in fibra di latte dalla designer e docente di moda lucana Damiana Spoto.
Nei prossimi mesi i ceramisti liguri amplieranno la mandria con le loro opere, che verrannoesposte assieme a quelle dei colleghi castellamontesi a maggio a Savona durante il Festival della Maiolica, per poi spostarsi nuovamente ad agosto a Castellamonte in occasione della 64^ Edizione della Mostra della Ceramica.
- Dettagli
- Categoria: Cultura
Cultura
L’anno scorso è stato il 90° anniversario della morte di Francesco Ruffini, giurista, storico, politico e antifascista, e ora tre associazioni culturali eporediesi – Forum Democratico del Canavese Tullio Lembo, ASAC-Associazione di Storia ed Arte Canavesana e Associazione Mario Clemente – hanno organizzato un duplice appuntamento per celebrare la sua grande figura politica, scientifica e culturale. La commemorazione, intitolata “Francesco Ruffini maestro di libertà. A novant’anni dalla scomparsa”, patrocinata dalla Città metropolitana di Torino, si terrà giovedì 6 febbraio, con un convegno a Ivrea, e sabato 8 febbraio, con una cerimonia a Borgofranco. Due località scelte non a caso: a Ivrea, precisamente al Liceo Botta, Ruffini si diplomò, mentre a Borgofranco trascorse gli ultimi anni della sua vita ed è sepolto.Il convegno del 6 febbraio si svolgerà a partire dalle 17 nella sala Santa Marta, e sarà moderato da Francesco De Giacomi. Dopo i saluti istituzionali, tra cui quelli di Sonia Cambursano, consigliera delegata della Città metropolitana di Torino, interverranno: Mario Dogliani, professore emerito di Diritto costituzionale all’Università di Torino, che ricorderà il ruolo del grande studioso nelle ricerche sull'origine della libertà; Andrea Frangioni, storico, autore di una biografia del Ruffini, che inquadrerà il suo ruolo nella vita politica dei primi decenni del ‘900; Edoardo Pesce, ricercatore in diritto privato all’Università di Genova, che si è diplomato con lode al Liceo Botta. I loro interventi saranno preceduti dai contributi di alcuni allievi delle ultime classi del Liceo: il convegno, infatti, oltre a commemorare Francesco Ruffini, intende rendere vivo il suo ricordo alle generazioni che si affacciano alla vita adulta.
La cerimonia di sabato 8 febbraio a Borgofranco comincerà alle 10.30, davanti alla casa di Ruffini e sarà allietata dalle musiche suonate dalla Banda musicale locale. Preceduti dai saluti istituzionali, si terranno gli interventi delle associazioni che hanno organizzato la commemorazione. Al termine, sarà deposta una corona di alloro sulla tomba.
Gli organizzatori ricordano che Francesco Ruffini “per il Canavese è una delle figure di rilievo nazionale degli ultimi 150 anni, accanto a Massimo D’Azeglio, Costantino Nigra, Giuseppe Giacosa, Adriano Olivetti e Piero Martinetti. Liberale cavouriano, giurista, senatore, ministro, strettamente legato a Croce e Albertini, è stato partecipe di molti snodi cruciali delle vicende italiane dell’epoca. Protagonista nella critica ai Patti Lateranensi e nel rifiuto imposto dal regime ai docenti universitari”. Ruffini, infatti, è ricordato anche perché fu uno dei 12 docenti universitari italiani che nel 1931 rifiutarono il giuramento di fedeltà al regime fascista.
La commemorazione dei 90 anni, che si avvale del sostegno della Fondazione Ruffini, ha dei precedenti illustri: nel 1954 fu lo stesso Presidente della Repubblica Luigi Einaudi a commemorare uno dei suoi maestri a venti anni dalla scomparsa, mentre nel 1984 la sua memoria fu onorata, proprio a Borgofranco, da Norberto Bobbio e Alessandro Galante Garrone.

- Dettagli
- Categoria: Cultura
Cultura
Con il sostegno della Città di Chivasso attraverso il Bando MusicArt 2025 e con il patrocinio della Città metropolitana di Torino, sabato 18 gennaio alle 21 al teatro dell’Oratorio Beato Angelo Carlettiè in programma ilsecondo appuntamento della stagione Chivasso in Musica 2025. Si tratta del Concerto di San Sebastiano, realizzato con la partecipazione e il sostegno del Magnifico Coro degli Abbà. Protagonisti della serata saranno gli Archi dell’Orchestra sinfonica Bartolomeo Bruni di Cuneo, che svilupperanno un programma intitolato “Viaggio musicale nell’Italia del ‘700”, che comprende composizioni di autori operarono nel corso del XVIII secolo a Venezia, Lucca, Milano, Napoli, Torino. La vivacità musicale settecentesca verrà evidenziata dalle note del compositore italiano più amato del periodo barocco: Antonio Vivaldi, di cui sarà eseguita l’Ouverture dall’opera “L’Incoronazione di Dario”, andata in scena per la prima volta al Teatro Sant’Angelo di Venezia nel 1717. A seguire un’altra pagina veneziana di Tomaso Albinoni, la Sinfonia in Sol minore per archi e basso continuo opera 2 numero 11. Si passerà, quindi, a Lucca con il Concerto grosso op.3 n. 1 in Re maggiore di Francesco Geminiani, per poi raggiungere Milano con Andrea Bernasconi, del quale sarà eseguita la Sinfonia in La maggiore. Napoli che si potrà scoprire attraverso quattro compositori: Nicolò Jommelli con la Sinfonia numero 3 in Re Maggiore, Giovanni Battista Pergolesi con la Sinfonia in Sol maggiore, Giuseppe Scarlatti con la Sinfonia in Fa maggiore e Giuseppe Porsile con la Sinfonia numero 2 in Re maggiore. La musica barocca di Torino verrà ricordata con la Sinfonia in Do maggiore di Giovanni Antonio Giai, mentre la conclusione sarà ancora una volta affidata ad Antonio Vivaldi con il Concerto per archi in Fa maggiore.Invece domenica 19 gennaio alle 18,30 nel Duomo di Santa Maria Assunta a Chivasso, sarà celebrata l’Eucarestia in onore di San Sebastiano martire, patrono del Magnifico Coro degli Abbà dello Storico Carnevale. La Messa sarà presieduta dal canonico Davide Smiderle, prevosto dell’Insigne Collegiata e Priore degli Abbà. L’animazione liturgica sarà curata dalla Cappella Musicale “Santa Maria Assunta” della Cattedrale di Ivrea, diretta da Maria Ausilia Fiorina. Alla consolle dell’organo Felice Bossi risalente al 1843, siederà l’organista eporediese Alessandro Veneri.
Per saperne di più si può consultare il sito Internet www.associazionecontatto.it, scrivere a info@associazionecontatto.it o chiamare il numero telefonico 011-2075580.
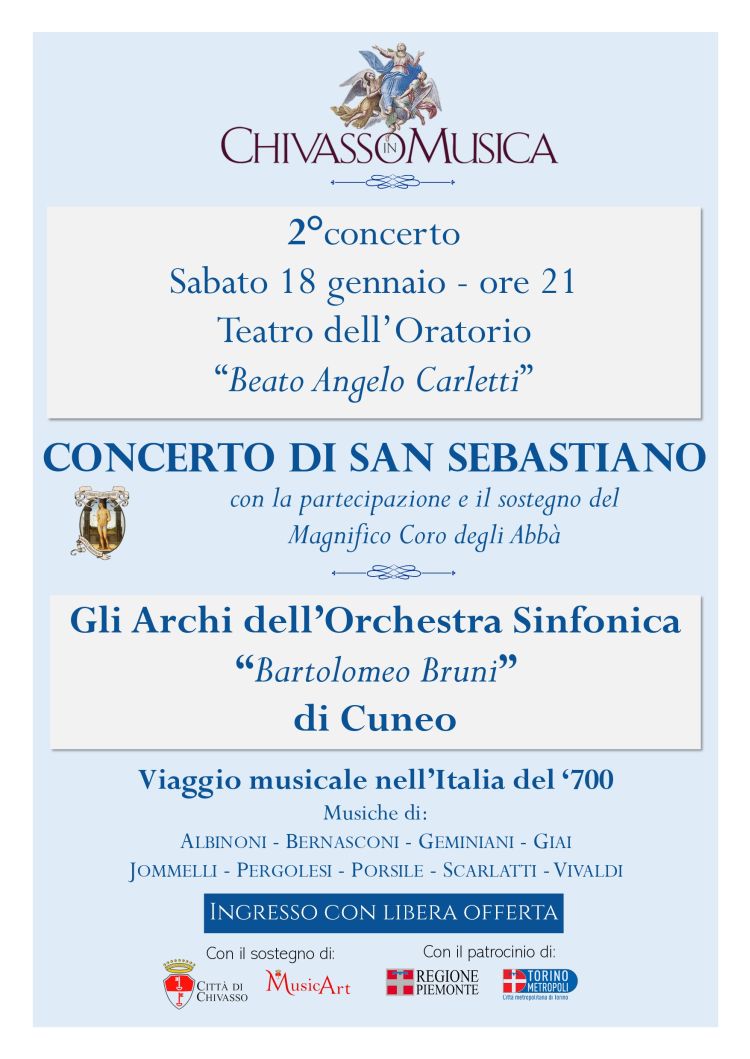
- Dettagli
- Categoria: Cultura
Cultura
Da sabato 28 dicembre e per i giorni delle festività invernali, comprese le domeniche di gennaio e febbraio, una navetta gratuita collegherà il paese di Fenestrelle con Pra Catinat, dove sorge una struttura ricettiva e da dove si può proseguire poi a piedi - o con sci e ciaspole - fino al Rifugio Selleries.
L'iniziativa è stata concordata tra l'Unione Montana Val Chisone e Germanasca, il Comune di Fenestrelle e la Città metropolitana di Torino.
"Verseremo un contributo in denaro all'Unione Montana per coprire il costo della navetta rivolta ai turisti che non saliranno più con l'auto privata fino a Pra Catinat o al Rifigio Selleries. La zona rientra nel Parco Alpi Cozie, va tutelata dal punto di vista ambientale e promossa dal punto di vista turistico - commenta il vicesindaco di Città metropolitana di Torino Jacopo Suppo - e dobbiamo anche prevenire problemi alla sicurezza stradale causati da quanti parcheggiano incautamente sul ciglio della strada. Avviamo questa sperimentazione e valutiamo i risultati".
Suppo ha incontrato Danilo Breusa, presidente dell'Unione montana, e Michael Bouquet sindaco di Fenestrelle per concordare interventi condivisi.
La navetta sarà disponibile il 28, 29, 30 e 31 dicembre. E poi domenica 5-12-19-26 gennaio e 2-9-16-23 febbraio con partenza ore 9.45 da Piazza della Fiera di Fenestrelle e ritorno da Pra Catinat alle ore 15.45.
Per garantire un miglior servizio è consigliato prenotare tramite un messaggio al numero +39 347 5895250
- Dettagli
- Categoria: Cultura
