Cultura
È il gruppo dei Credendari del Cerro, associazione storico-culturale della Città di Ciriè, ad animare la visita mensile di oggi, sabato 20 novembre, alle sale storiche di Palazzo Cisterna, sede aulica della Città metropolitana di Torino. I Credendari sono un gruppo nato nel settembre 2009 dalla passione comune di alcuni amici verso le antiche tradizioni artigiane e lo studio dell’epoca tardo-medievale, in particolare quella delle vicende legate alla Casata dei Savoia avvenute nel territorio delle Valli di Lanzo e del Canavese tra fine ‘300 e inizio ‘400. Le loro attività sono volte a portare il visitatore a diretto contatto con la “storia vivente“, in una situazione il più possibile veritiera, dove egli possa fare un ritorno indietro nel tempo da protagonista, in un contesto dove poter muoversi e interagire con personaggi e manufatti dell’epoca.Le visite a Palazzo Cisterna sono gratuite con prenotazione obbligatoria a: urp@cittametropolitana.torino.it o telefonando dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 al numero 011-8617100.
Prossimo appuntamento: sabato 18 dicembre.

- Dettagli
- Categoria: Cultura
Cultura
Gli spazi juvarriani dell’Archivio di Stato di Torino, in piazzetta Mollino, ospitano fino al 7 gennaio “Le favole della pittura”, una mostra promossa dall'Archivio Tabusso e da Banca Sella che ripercorre gli oltre sessant'anni di attività di Francesco Tabusso, ultimo pittore cantastorie molto legato alla Valle di Susa e alla sua Rubiana.L’esposizione di Tabusso è il tema della prima puntata di “Segni d’arte”, la nuova rubrica dedicata a mostre e iniziative artistiche del territorio.
A questo link https://www.14dd5266c70789bdc806364df4586335-gdprlock/watch?v=uZ52vVwHLUk
le interviste a Paola Tabusso, vicepresidente dell’Archivio, e a Daniela Magnetti, direttore artistico di Banca Patrimoni Sella.
La mostra presenta una selezione di circa sessanta opere provenienti da collezioni pubbliche e private: opere di grande formato, coloratissime, alcune mai esposte che invitano a scoprire una realtà fuori dal tempo, a contatto con la natura. Tabusso con i suoi quadri ci fa evadere per un attimo dal caos della vita moderna, proiettandoci in una realtà contadina miticamente fuori dal tempo, in cui poter recuperare uno sguardo fanciullesco sul mondo.
“Le favole della pittura” coincidono con il decennale della morte dell'artista avvenuta nel gennaio 2012 e ripercorrono gli oltre sessant'anni di attività del pittore che ha sempre esplorato strade solitarie, al di là delle mode e dei movimenti, conquistando non solo l'apprezzamento della critica, ma anche dei non addetti ai lavori.
Il percorso espositivo non si limita al solo Archivio di Stato, ma proseguirà idealmente anche nel territorio di Rubiana, dove dai primi del ‘900 c’è la casa di famiglia di Tabusso: la Biennale Fiabe e Boschi, promossa dall’amministrazione comunale per ricordare il suo cittadino onorario, celebrerà nel 2022 la X edizione con mostre e iniziative diffuse nelle borgate, visita a casa Tabusso e alla Pinacoteca comunale intitolata al pittore.
I filmati dei “Segni d’Arte”vengono messi in onda dall’emittente televisiva locale Grp sul canale 114 del digitale terrestre, il venerdì alle 21,30, il sabato alle 13,45 e la domenica alle 20,45.
Il reportage video sulla mostra “Le favole della pittura” pubblicato sul canale YouTube della Città metropolitana di Torino e la fotogallery sono reperibili sul portale Internet della Città metropolitana, alla pagina http://www.cittametropolitana.torino.it/speciali/2021/segni_arte/
- Dettagli
- Categoria: Cultura
Cultura
Una storia di generosità e di libri donati che parte da una frazione di Frabosa Soprana, nel Cuneese, passa da Collegno e giunge alla biblioteca storica della Città metropolitana a Palazzo Cisterna. La vicenda riguarda la donazione di una cinquantina di libri antichi, pubblicati tra il 1772 e il 1933, che le sorelle collegnesi Alda e Graziella Viglione hanno destinato alla biblioteca “Giuseppe Grosso” e che andranno presto a costituire il fondo “Lucia Bersezio Viglione”. I libri che le sorelle Viglione hanno destinato alla biblioteca di Palazzo Cisterna provengono dal ramo famigliare materno Bersezio, e più precisamente da Don Giovanni Bersezio, deceduto nel 1949, parroco per circa 40 anni a Fontane di Frabosa, in provincia di Cuneo. “Don Giovanni Bersezio era zio paterno di nostra mamma Lucia Bersezio Viglione” spiegano Alda e Graziella Viglione, “e proprio alla nostra mamma vorremmo dedicare questa donazione di libri”.La collezione donata alla Città metropolitana comprende i tre libri del trattato filosofico di Cicerone De officiis (lat., Sui doveri) nell’edizione del 1780, Augustae Tautinorum ex Typographia Regia e un altro testo settecentesco, la Nuova Guida de’ Forestieri, Napoli, a spese di Saverio Roffi Librario del 1772. Sono presenti molti libri dell’800, tra cui i tre volumi della Commedia di Dante Alighieri, stampata nel 1869 a Milano da Francesco Pagnoni Tipografo Editore, e il testo P. Virgilii Maronis Opera, Augustae Tautinorum ex Officina Regia, edito nel 1850. Non mancano poi le Opere complete di Silvio Pellico, 1875, Napoli Stabilimento Tipografico del Guttemberg, e il Don Chisciotte della Mancia, pubblicato a Milano da Sonzogno nel 1896.
- Dettagli
- Categoria: Cultura
Cultura
Proseguono nel mese di novembre le visite animate a Palazzo Dal Pozzo della Cisterna, sede aulica della Città Metropolitana di Torino, in via Maria Vittoria 12. L’appuntamento, previsto per le ore 10 di sabato 20 novembre, vede la partecipazione del gruppo storico iscritto all’Albo della Città metropolitana di Torino I Credendari del Cerro, associazione storico culturale della Città di Ciriè, nata nel settembre 2009 da una passione comune di un gruppo di amici verso l’artigianato e lo studio dell’epoca tardo-medievale, in particolare quella riguardante le vicende legate alla Casata dei Savoia avvenute nel territorio delle Valli di Lanzo e del Canavese tra fine ‘300 ed inizio ‘400. Dalla combinazione di queste due attività, il gruppo ha presto determinato una propria identità, ritrovando nella disciplina della ricostruzione storica la massima espressione di queste arti. Sono infatti i Credendari del Cerro gli organizzatori dell’ultima edizione di Chiamata alle Arti, rievocazione storica che si è svolta nel settembre 2019 al Castello Malgrà di Rivarolo Canavese.
Fermato dal lockdown il Gruppo storico ritorna a Palazzo Cisterna con l'augurio di poter presto organizzare nuovamente grandi eventi di piazza.
Le visite a Palazzo Cisterna sono gratuite con prenotazione obbligatoria a:
urp@cittametropolitana.torino.it o telefonando dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 al numero 011-8617100.
Prossimo appuntamento: sabato 18 dicembre.
MODALITA’ DI ACCESSO
Per partecipare alla visita occorre:
- essere in possesso di certificazione verde (Green Pass) COVID-19, così come previsto dal Decreto-Legge 23 luglio 2021, n.105, per musei, mostre, istituti e luoghi della cultura;
- indossare la propria mascherina e igienizzarsi le mani con il gel posto all’ingresso;
- mantenere la distanza di almeno 1 metro con gli altri visitatori e il personale di Palazzo.

- Dettagli
- Categoria: Cultura
Cultura
Il duo pianistico Valente-Larosa sarà protagonista del prossimo concerto di “Preludi”, la prima parte della stagione 2021-2022 dell’Accademia di Musica di Pinerolo, patrocinata dalla Città Metropolitana di Torino. L’appuntamento è per martedì 9 novembre alle 20,30 nella sala concerti di viale Giolitti 7 a Pinerolo. Giovanna Valente è una fra le più autorevoli musiciste della scuola pianistica di Bari, mentre Imma Larosa è una delle sue più brillanti allieve. Sono entrambe docenti presso il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari. Il duo Valente-Larosa presenterà un programma dedicato all’arte della trascrizione, con la Sinfonia numero 6 in fa maggiore opera 68 Pastorale di Ludwig van Beethoven trascritta da Hugo Ulrich e con “La Mer” di Claude Debussy, considerata come una delle migliori opere per orchestra del ventesimo secolo, trascritta per pianoforte a quattro mani dall’autore stesso. La trascrizione di un pezzo musicale è l’adattamento di una composizione a un mezzo fonico, vocale e strumentale, diverso da quello cui era originariamente destinato; non sempre, però, questo adattamento assurge al livello di ricreazione artistica. Nel caso della Pastorale di Beethoven la trascrizione di Ulrich ricrea tutte le singole parti orchestrali che stanno dentro le partiture delle 9 sinfonie di Beethoven.
I successivi appuntamenti della stagione 2021/22 dell’Accademia di Musica di Pinerolo sono:
- domenica 21 novembre “Notte trasfigurata” con il Sestetto Wanderer composto da strumentisti del Teatro alla Scala, affiancato da Edgardo Faure neuropsicologo e psicoterapeuta
- martedì 30 novembre “Francia fin de siècle” per il ciclo “Fauré”, con Antonio Valentino, Simone Briatore, Sawa Kuninobu e Matteo Ferraro
- il concerto di Natale di martedì 14 dicembre con il Coro da camera di Torino diretto da Dario Tabbia.
L’accesso ai concerti è possibile solo con Green Pass e mascherina. La prenotazione è obbligatoria al numero telefonico 0121-321040 o all’indirizzo e-mail noemi.dagostino@accademiadimusica.it

- Dettagli
- Categoria: Cultura
Cultura
Si presenta giovedì 4 novembre alle ore 18,00 a Palazzo dal Pozzo della Cisterna, sede aulica della Città metropolitana di Torino, il libro di Roberto Rossi Precerutti “San Giacomo di Stura – Un monastero medievale alle porte di Torino” pubblicato da Neos Edizioni.
Un libro per scoprire un momento importante del Medioevo torinese attraverso le vicende del monastero vallombrosano. Sorto verso la metà del XII secolo (1146), il monastero vallombrosano di San Giacomo di Stura è uno dei fondamentali monumenti storico-artistici della civiltà medievale torinese. La fondazione religiosa ha svolto, nel periodo di massima fioritura, una funzione essenziale di assistenza a poveri, pellegrini e viandanti in un’area attraversata da una diramazione della via Francigena, rivelando una chiara vocazione stradale e costituendo un’interlocuzione importante, soprattutto dal punto di vista sociale, sia con il vescovo e il comune, sia con le realtà signorili del contado e le dinastie dei Savoia e dei Monferrato. Oggi, purtroppo, le vestigia dell’abbazia, collocate presso una strada di grande scorrimento che unisce Torino a Settimo, versano in stato di abbandono nonostante l’inizio di alcuni lavori di restauro e non sono visitabili.
Il volume è corredato da una ricca serie di tavole di Emilia Mirisola che vogliono ricostruire la suggestione del monastero nel suo periodo di splendore. L’introduzione è di Davide Belgradi.
Roberto Rossi Precerutti
Poeta, saggista e traduttore, Roberto Rossi Precerutti è nato a Torino nel 1953 da famiglia piemontese di antica origine, i Rossi dalla Manta, al cui ramo fiorentino appartenne Ernesto Rossi, illustre antifascista propugnatore del federalismo europeo. Laureatosi in Lettere moderne presso l’Ateneo subalpino con una tesi di Istituzioni medievali dedicata a San Giacomo di Stura (relatore Giuseppe Sergi), ha pubblicato gran parte della sua produzione poetica presso gli editori Crocetti (Rimarrà El Greco, 2015), Aragno (Un impavido sonno, 2019) e Neos (Il sogno del cavaliere, 2021). Più volte finalista al Premio Viareggio-Poesia, gli sono stati conferiti prestigiosi riconoscimenti quali i Premi Lorenzo Montano (2001), Mondello (2006), Val di Comino (2009), Il Meleto di Guido Gozzano (2021).
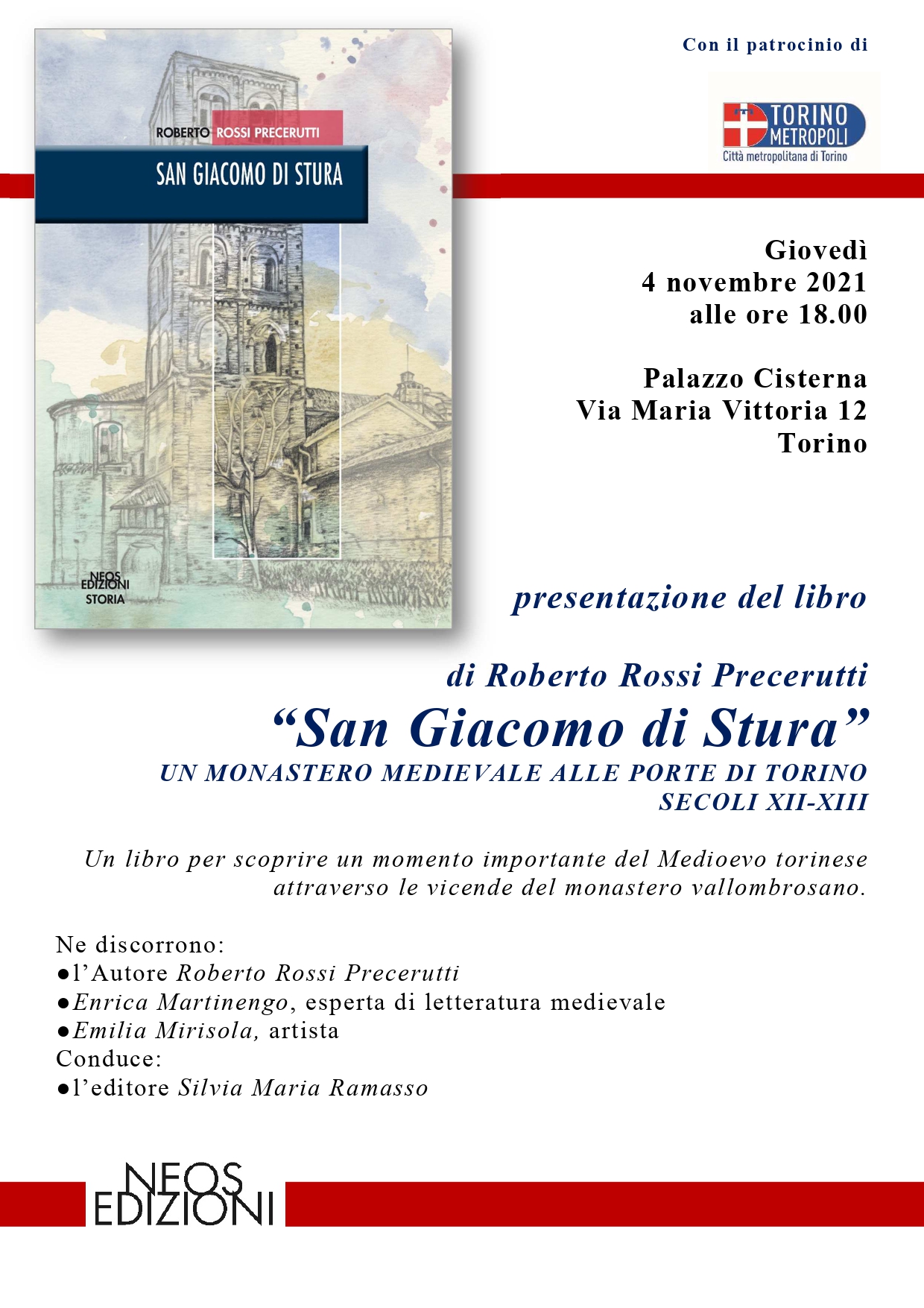
- Dettagli
- Categoria: Cultura
Cultura
La rassegna “I sentieri della Cultura – Chivasso in Musica 2021”, patrocinata dalla Città Metropolitana di Torino, prosegue con il terzo appuntamento, in programma giovedì 11 novembre alle 21 nella chiesa parrocchiale dedicata ai Santi Giovanni Battista e Rocco nella frazione Castelrosso (uscita autostradale consigliata Chivasso Est o Rondissone). Il concerto intitolato “Arpa latina” sarà proposto dalle arpiste Vanja Contu, Valeria Delmastro e Michela Marcacci e dal percussionistaAlan Brunetta. Si tratta di un ensemble musicale di tutto rispetto, che si è impegnato per tre anni in ricerche musicologiche, per arrivare ad un importante appuntamento con una serie di composizioni di autori latino-americani o europei trapiantati, quali il costaricano Camacho Camacho, il cubano Alfredo Rolando Ortiz, il francese naturalizzato colombiano Carlos Gardel, accanto a Deborah Henson Conant e a Bernard Andrès. Non mancherà un omaggio al più celebre dei compositori sudamericani, l’argentino Astor Piazzolla, del quale quest’anno si celebra il centenario della nascita.
La serata vuole anche essere un omaggio alla castelrossese Daniela Chiavarino, Presidente per l’anno 2021-22 del Rotary Club di Chivasso, che organizza il concerto insieme all’associazione culturale Contatto.
L’accesso del pubblico sarà consentito a partire dalle 20,30, con ingresso a libera offertae l’obbligo di esibire il Green Pass.
Per favorire la più ampia partecipazione del pubblico chivassese, sarà messa a disposizione una navetta gratuita che partirà da Piazza d’Armi alle 20.
Per saperne di più si può consultare il portale Internetwww.chivassoinmusica.it, scrivere a info@chivassoinmusica.ito chiamare il numero telefonico 011-2075580.

- Dettagli
- Categoria: Cultura
Cultura
A partire da venerdì 5 novembre torna a Vinovo la XII edizione della manifestazione “Castello in Musica”, organizzata dall’associazione Amici del Castello e patrocinata, tra gli altri, dalla Città metropolitana di Torino. L’evento propone, per tutto il mese di novembre 2021, concerti di musica da camera nella splendida cornice del castello della Rovere, in piazza Rey.
Questo il programma completo delle serate:
• Si parte venerdì 5 novembre, alle ore 21, con Leonardo Locatelli che presenta “I grandi del pianoforte“. Durante la serata verranno eseguite musiche di Donizetti, Mozart, Beethoven, Rachmaninov, Satie, Albeniz e Liszt.
• Venerdì 12 novembre un quintetto per clarinetto e archi presenterà composizioni di Mozart e Brahms.
• Venerdì 19 novembre Giuseppe Barone (violino) e Cristina La Bruna (arpa) faranno ascoltare agli spettatori alcuni dei capolavori di Debussy, Oberthür, Shaposhnikov, Elgar, Von Wilm, Massenet, Paganini, Vieuxtemps e Andrès.
• Gli appuntamenti si concluderanno venerdì 26 novembre con il concerto per quintetto d’archi formato da giovani musicisti laureati al conservatorio.
Il costo del singolo concerto è di 12 euro, mentre l’abbonamento per le quattro serate ha un prezzo di 40 euro. Gli abbonamenti possono essere acquistati al castello della Rovere.
Info: Associazione Amici del Castello 338-231395.

- Dettagli
- Categoria: Cultura
Cultura
Quella di domenica 31 ottobre è l’ultima occasione dell’anno per visitare le dimore storiche aderenti all’itinerario pinerolese. Dai primi di novembre cancelli e portoni resteranno chiusi, in attesa della riapertura primaverile. I visitatori dovranno essere muniti del Green Pass o della certificazione di un tampone con esito negativo entro le 24 ore precedenti la visita, dovranno indossare la mascherina e mantenere le distanze previste nel corso delle visite e degli eventi. All’ingresso si potrà richiedere il Passaporto dell’Itinerario delle Dimore Storiche del Pinerolese, che agevola le visite successive e permette di collezionare i timbri apposti dalle dimore aderenti.
Nel millenario Castello di Marchierù di via San Giovanni 77 a Villafranca Piemonte le visite sono guidate dai proprietari, che accompagnano gli ospiti alla scoperta del parco, della cappella gentilizia, delle scuderie settecentesche e delle sale medioevali del maniero, dalle 10 alle 11, dalle 15 alle 16 e dalle 17 alle 18. Alle 15, alle 16 e alle 17 gli allievi dell’Istituto alberghiero Prever di Pinerolo servono agli ospiti prenotati una cioccolata calda all’uso antico. La prenotazione è obbligatoria a numeri telefonici 339.4105153 e 348.0468636 per il picnic e la cioccolata. L’ingresso al castello costa 8 euro per gli adulti ed è gratuito per i bambini fino a 10 anni. La visita al maniero abbinata alla degustazione di cioccolata costa 12 euro.
Il Castelletto di via Pinerolo 11 a Buriasco è aperto domenica 31 dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18. Oltre al giardino e all’azienda agricola con le scuderie, sono visitabili i saloni di rappresentanza, la selleria storica, la raccolta di carrozze con l’agriturismo e la cascina. L’ingresso costa 8 euro ed è gratuito per i bambini fino a 10 anni. I titolari di Passport e TorinoPiemontecard pagano 6 euro. È gradita la prenotazione al numero telefonico 335-6829581 o all’indirizzo e-mail info@castelletto.info
Nell’ultima domenica di ottobre alcastello di Miradolo di via Cardonata 2 a San Secondo di Pinerolo a partire dalle 17 grandi e piccini possono vivere un’avventura in maschera in occasione della notte di Halloween, con giochi, indovinelli e laboratori di circo, in collaborazione con la palestra Sportica di Pinerolo. A Miradolo prosegue inoltre la mostra “Oltre il giardino, l’abbecedario di Paolo Pejrone”, che propone un percorso fra le sale storiche, il parco e l’orto. La mostra è visitabile dalle 10 alle 17,30 al costo di 10 euro, comprensivo di ingresso al parco. La merenda per i bimbi costa 4 euro. La prenotazione è obbligatoria al numero telefonico 0121-502761 o all’indirizzoprenotazioni@fondazionecosso.it
La Villa Il Torrione di strada del Galoppatoio 20 a Pinerolo è visitabile domenica 31 ottobre dalle 10 alle 18,30. L’ingresso costa 6 euro ed è gratuito per i bambini fino a 10 anni. È obbligatoria la prenotazione al numero telefonico 0121-323358 o all’indirizzo e-mailsegreteria.torrione@gmail.com
Il Palazzotto Juva di via Agnelli 77 a Volvera è aperto nell’ultima domenica di ottobre dalle 10 alle 19 e si può ammirare l’esposizione degli abiti a cura dell’associazione Maison Tatì. Nel pomeriggio si può consumare la “Merenda al Palazzotto Juva”. L’ingresso costa 8 euro ed è gratuito fino a 10 anni. I possessori di Passport e TorinoPiemontecard pagano 7 euro. La prenotazione è obbligatoria al numero 339-5690121 o all’indirizzoarch.lilianacanavesio@gmail.com
La Casa Lajolo di via San Vito 21 a Piossasco è una villa settecentesca interessante per il suo giardino, per l’orto e per il tradizionale “prà giardin”. Il giardino all'italiana è stato inserito dal FAI nell’elenco dei beni da scoprire in Piemonte ed è articolato su tre livelli, collegati da scale in pietra. Al livello più alto vi è il piazzale prospiciente la casa padronale, delimitato da siepi di bosso, che caratterizzano più diffusamente il secondo livello. Questo a sua volta è suddiviso in due parti: un giardino all’italiana simmetrico con boschetto di tassi che crea una quinta verde, un giardino all’inglese. Il terzo settore ospita un frutteto e il pergolato. Le visite guidate alla casa, al giardino e all'orto-giardino hanno durata di circa un'ora, con partenza ogni mezz'ora dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 17. Alle 16 nel giardino sono in programma la presentazione e la degustazione del vino Erbaluce. L’ingresso e la visita della dimora costano 8 euro, ridotto 6. Per informazioni e prenotazioni si può scrivere a info@casalajolo o chiamare il numero 333-3270586.
Il castello dei conti Asinari Piossasco di via Contessa Birago 4 a Virle il 31 ottobre non è visitabile, ma è prevista un’apertura straordinaria domenica 14 novembre in occasione della Fiera d’ Autunno di Virle. Per informazioni si può chiamare il numero telefonico 335-6822260 o scrivere acastellopiossasco@gmail.com
Nel palazzo Ricca di Castelvecchio di via Vittorio Emanuele 15 a Bricherasio domenica 31 ottobre sono visitabilidalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30 le sale del primo e del secondo piano ed il giardino. Il biglietto d’ingresso costa 8 euro ed è ridotto a 5 per bambini e ragazzi fino ai 14 anni di età. I possessori del Passport e della TorinoPiemontecard pagano 7 euro. Per le prenotazioni si può chiamare il numero 338-7020341 o scrivere a palazzocastelvecchio@gmail.com

- Dettagli
- Categoria: Cultura
Cultura
La serie di reportage televisivi che la Direzione comunicazione e rapporti con i cittadini e il territorio della Città Metropolitana di Torino dedica ai “Restauri d’Arte” prosegue questa settimana con il filmato dedicato al Centro di conservazione e restauro “La Venaria Reale”.
I filmati dei “Restauri d’Arte”vengono messi in onda dall’emittente televisiva locale GRP sul canale 114 del digitale terrestre, il venerdì alle 21,30, il sabato alle 13,45 e la domenica alle 20,45.
Per visionare la playlist dei reportage video sinora pubblicati sul canale YouTube della Città metropolitana di Torinoe le fotogallery basta accedere al portale Internet della Città metropolitana, alla pagina
http://www.cittametropolitana.torino.it/speciali/2021/riflettori_restauri_arte/
Per visionare tutte le fotogallery dei Restauri d’Arte e scaricare le immagini: https://photos.app.goo.gl/aRNGGkHsSYPa6Arn9
RIENTRANO IN BIBLIOTECA LE OPERE PRESTATE PER IL RESTAURO AL CCR DI VENARIA
In questa insolita puntata dedicata ai restauri d’arte la Direzione comunicazione e rapporti con i cittadini e il territorio della Città Metropolitana non è andata a scoprire un luogo restaurato, ma un luogo dove si restaura e si impara a restaurare: il Centro di conservazione e restauro “La Venaria Reale” e in particolare il Laboratorio di carta e fotografia. È qui infatti che, d’intesa con la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino e grazie a una collaborazione tra la Città Metropolitana e il Centro, alcune opere appartenenti alla Biblioteca di Storia e cultura del Piemonte Giuseppe Grosso sono diventate, in occasione di un intervento conservativo, materia di studio per i restauratori del futuro. Si tratta in particolare di un prezioso negativo calotipico di Luigi Sacchi, di cinque fotografie di soggetto romano appartenenti alla raccolta Parenti e di altre venti opere, tra disegni e incisioni, appartenenti alla raccolta Arti Grafiche Dragone.
Come ha spiegato la docente Tiziana Macaluso, “gli interventi di restauro che sono stati realizzati sono minimi, si tratta di puliture e consolidamenti di piccole pieghe marginali o suture di lacerazione di lieve entità, localizzate sempre lungo i margini e ancora interventi di consolidamento delle mediazioni grafiche. In particolare, in alcune opere, erano presenti anche nastri adesivi o residui di adesivi e sono stati rimossi con solventi su tavolo aspirante. Per quanto riguarda il nucleo di fotografie stampate su carta all'albumina l’intervento ha riguardato soprattutto puliture e piccoli consolidamenti di sollevamento ed è stato anche molto localizzato sui cartoni di supporto secondario”. L’intervento sul calotipo di Luigi Sacchi “Figura maschile seduta, con tromba, 1852-53”, già precedentemente restaurato, ha riguardato la realizzazione di un nuovo montaggio che permette la visione del calotipo sia sul recto che sul verso. Tutte le opere, prese in prestito dal CCR “La Venaria Reale” alla fine del 2018, sono state inserite all'interno di materiali idonei alla lunga conservazione e sono così rientrate nella Biblioteca storica della Città Metropolitana.
Grazie alla convenzione stipulata tra il Centro di conservazione e restauro e l’Universitàdegli Studi di Torino, è attivo da qualche anno il corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali –SUSCOR. “Il corso di Laurea – spiega il professor Daniele Castelli, direttore del SUSCOR - prevede diversi percorsi formativi, a seconda delle tipologie di materiale con cui sono realizzate le opere. Ipercorsi formativi accreditati sono cinque e il quinto è proprio quello dedicato ai materiali cartacei e fotografici. Questo percorso formativo, accreditato più recentemente rispetto agli altri, è arrivato oggi al quinto anno e quindi gli studenti, dopo aver svolto un loro percorso formativo nei primi quattro anni, si apprestano nel nuovo anno accademico ad avere i progetti di tesi assegnati proprio su questa specifica tipologia di materiali”.

- Dettagli
- Categoria: Cultura
